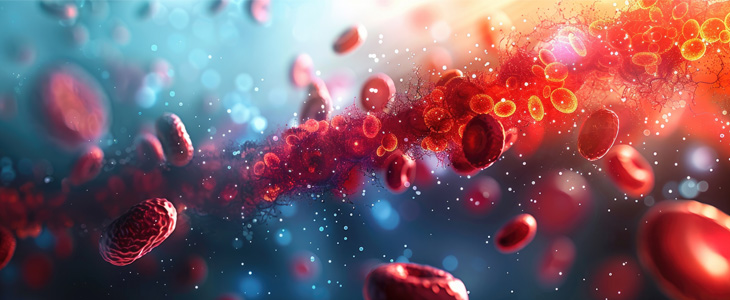In mancanza di linee guida condivise e scoraggiati dagli esperti anglosassoni1, i medici italiani sono sempre più dubbiosi sull’opportunità o meno di ricercare alterazioni trombofiliche nei pazienti affetti da tromboembolismo venoso (TEV).
La fotografia della situazione è presentata in modo chiaro da un recente studio pubblicato su Blood Transfusion dai ricercatori del registro START 22: in Italia ci sono centri emostasi e trombosi che testano il 99,7 % dei pazienti ed altri che sottopongono ad accertamenti per trombofilia solo un selezionatissimo 2,9%. Le percentuali di positività sono inversamente proporzionali al numero di pazienti testati andando da un 9,5 % nel primo caso fino ad un 100% nel secondo caso.
Ma come cambia la gestione clinica del paziente risultato positivo al test per trombofilia e, soprattutto, come ci si comporta se la positività riguarda alterazioni trombofiliche su base genetica “severe” (come la presenza di deficit di proteina C, S, antitrombina o difetti combinati) piuttosto che difetti “lievi” (eterozigosi per fattore V Leiden o Protrombina) o, ancora, la presenza di sindrome da anticorpi antifosfolipidi (APLS)?
Solo in quest’ultimo caso l’atteggiamento del medico sembra cambiare significativamente portando ad una durata più prolungata della terapia. Diversamente, anche se i pazienti con difetti “lievi” sospendevano più spesso la terapia dopo sei mesi rispetto a quelli con difetti “severi” (47.8 % dei casi vs 42.8%, p=0.0268), questa differenza è risultata meno marcata di quello che ci si sarebbe potuti aspettare sulla base del rischio decisamente maggiore di recidiva trombotica dei pazienti con difetto congenito di anticoagulanti naturali (proteina C, S ed antitrombina)3.
Nel complesso, circa la metà dei pazienti affetti da TEV valutati dal registro ha sospeso la terapia dopo 6 mesi, sia nel gruppo dei trombofilici (non APLS) sia nel gruppo di quelli senza trombofilia, documentando come nella decisione sul proseguimento o meno della terapia il risultato dei test genetici per trombofilia (che non sono inclusi nei principali score per la valutazione rischio di recidiva come HERDOO2, DASH e Vienna) venga poco valorizzato.
Un po’ diverso il discorso in termini di scelta del tipo di terapia anticoagulante. Dallo studio, infatti, emerge che i pazienti con difetti congeniti “severi” e quelli con APLS venivano trattati in numero significativamente maggiore con anticoagulanti “tradizionali” (antagonisti della vitamina K o AVK) mentre gli altri ricevevano più facilmente gli anticoagulanti orali diretti (DOAC). Il razionale di questa scelta nei pazienti affetti da APLS è supportato, tra gli altri, anche dai dati di un recente studio randomizzato che ha documentato come vi fosse un maggior numero di recidive trombotiche nei pazienti con APLS ad alto rischio (tripli positivi) trattati con rivaroxaban rispetto a quelli in terapia con warfarin4.
Nel caso dei pazienti portatori di alterazioni trombofiliche su base genetica, nonostante l’utilizzo dei DOAC sia ormai invalso nella pratica clinica, la discussione è ancora aperta ed alcuni medici ritengono più sicuro utilizzare i tradizionali e “più affidabili” AVK nei casi più severi. Tuttavia, più del 60% dei pazienti valutati nel registro START ed affetti da trombofilia erano in terapia con DOAC e soltanto due dei sette eventi trombotici registrati durante il follow-up hanno interessato pazienti che stavano assumendo questo tipo di farmaci. Ciò confermerebbe i risultati di una recente review e metanalisi5 sull’appropriatezza dell’utilizzo di questa classe di farmaci nei pazienti con tromboembolismo venoso e trombofilia ereditaria.
In conclusione, non sorprende che, a fronte di indicazioni scarse e non univoche da parte delle società scientifiche, il clinico adotti atteggiamenti molto differenti nella ricerca di alterazioni trombofiliche nei pazienti affetti da trombembolismo venoso e che i risultati di questa ricerca entrino poco in gioco nelle decisioni terapeutiche. Tuttavia, lo studio documenta una corretta tendenza a somministrare i “tradizionali” AVK nel paziente ad alto rischio con sindrome da anticorpi antifosfolipidi ed aggiunge elementi a conferma dell’appropriatezza del trattamento con DOAC nei pazienti affetti da trombofilia su base genetica, anche nelle forme più severe.
Bibliografia
- Connors JM. Thrombophilia testing and venous thrombosis. N Engl J Med 2017; 377: 1177-87
- Legnani C, Palareti G, Antonucci E, et al. Thrombophilia testing in the real-world clinical setting of thrombosis centres taking part in the Italian Start 2-Register. Blood Transfus. 2021;19(3):244-252. doi: 10.2450/2021.0262-20
- Brouwer JL, Lijfering WM, Ten Kate MK, et al. High long-term absolute risk of recurrent venous thromboembolism in patients with hereditary deficiencies of protein S, protein C or antithrombin. Thromb Haemost 2009; 101: 93-9.
- Pengo V, Denas G, Zoppellaro G, et al. Rivaroxaban vs warfarin in highrisk patients with antiphospholipid syndrome. Blood 2018; 132: 1365-7.
- Elsebaie MAT, van Es N, Langston A, et al. Direct oral anticoagulants in patients with venous thromboembolism and thrombophilia: a systematic review and meta-analysis. J Thromb Haemost 2019; 17: 645-56.